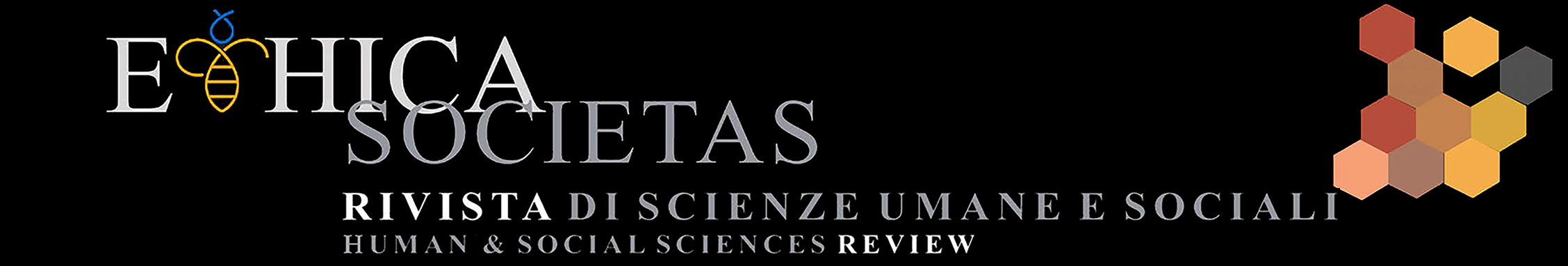Come trasformare il peso dell’uniforme in resilienza e prevenire il burnout nelle forze di polizia

Abstract: Il burnout e lo stress lavoro-correlato sono problematiche diffuse nelle forze di polizia italiane, con conseguenze drammatiche legate al malessere psicologico e a un allarmante incremento dei suicidi tra gli operatori in divisa. L’articolo esamina le cause principali, le implicazioni per la salute mentale e professionale e presenta una sintesi delle strategie di prevenzione più efficaci, basata su evidenze scientifiche europee e internazionali, oltre che pratiche applicative. Il focus è rivolto ad un approccio integrato che include formazione, supporto psicologico, miglioramenti organizzativi e cambiamento culturale, finalizzato a tutelare la salute degli agenti e garantire la sicurezza sociale.
Keywords: #burnoutpolizia #stresslavorocorrelato #sindromedacorridoiopolizia #prevenzioneburnout #salutementaleagentidipolizia #suicidioforzedipoliziaItalia #resilienzaoperatoridipolizia #supportopsicologicopolizia #benesserementalepolizia #stresscronico #sistemaimmunitario #psiconeuroendocrinoimmunologia #salutepsicofisica #infiammazione #forzedipolizia #polizialocale #poliziamunicipale #deborahbreda #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #ethicasocietasupli
ALTRI CONTRIBUTI SUL TEMA
LA SINDROME DEL CORRIDOIO: QUANDO IL MURO TRA VITA E LAVORO CROLLA
NON EROI, MA UMANI: IL DOLORE NASCOSTO DI CHI INDOSSA UNA DIVISA, UNA CORAZZA CHE UCCIDE
UN ALTRO SUICIDIO TRA LE DIVISE, ADDIRITTURA UNA DONNA INCINTA DELLA POLIZIA LOCALE
Introduzione
In Italia come in Europa, le forze di polizia sono quotidianamente esposte a condizioni di lavoro estreme: non solo ai traumi degli interventi sul campo, ma anche allo stress silenzioso di turni irregolari e di una burocrazia sempre più pressante. Questo mix esplosivo favorisce l’insorgere di patologie come il burnout e la “sindrome da corridoio“, con conseguenti disturbi d’ansia, depressione e un rischio suicidario in netta ascesa. Recenti statistiche mostrano un incremento preoccupante dei suicidi nel settore, con 471 casi registrati tra il 2014 e il 2024 e un’ulteriore recrudescenza nel 2025. Questa emergenza psicologica evidenzia la necessità di un intervento immediato e articolato che consideri le specificità della professione e il contesto lavorativo.
Proprio per comprendere le radici di questa crisi, l’articolo originale “La Sindrome da Corridoio: quando il muro tra vita e lavoro crolla” esplora una dinamica psicologica devastante: la perdita totale del confine tra vita privata e professione. Questa sindrome logora l’agente nella sua interezza, emotiva e relazionale, diventando l’anticamera del burnout. Si manifesta come un cortocircuito continuo in cui le pressioni professionali e familiari si amplificano reciprocamente, senza che vi sia più uno spazio vitale per decomprimere. Studi italiani confermano che lo stress organizzativo, come relazioni disfunzionali, sovraccarichi burocratici e carenza di personale, pesa più dell’esposizione diretta al trauma operativo nel determinare ansia e burnout tra gli operatori.
Riferimenti internazionali e letteratura straniera
La problematica del burnout nelle forze di polizia è ampiamente riconosciuta a livello globale, con studi condotti in Nord America, Europa, Australia e altri continenti. Questi evidenziano come il burnout e lo stress lavoro-correlato siano collegati a molteplici fattori, inclusi incidenti critici, esposizione ripetuta a traumi, e condizioni organizzative sfavorevoli. Nel Nord America, i programmi di Stress Inoculation Training (SIT) e debriefing post-traumatico riducono significativamente i sintomi di burnout e aumentano la resilienza degli agenti (Southwick & Charney, 2018). In Europa, Paesi come Germania, Regno Unito e Paesi Bassi hanno adottato monitoraggi psicologici periodici obbligatori e reti di supporto integrate, risultando in miglioramenti della salute mentale e riduzione dell’assenteismo correlato allo stress. L’OMS nel 2023 raccomanda un modello integrato che include formazione continua, supporto psicologico tempestivo e una leadership consapevole per identificare precocemente i segnali di disagio ed abbattere lo stigma legato alla debolezza emotiva (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2023).
Cause e fattori di rischio: un quadro multifattoriale
Il burnout nelle forze di polizia non nasce da un’unica causa, ma da una costellazione di pressioni che, sommandosi nel tempo, erodono le difese psicologiche dell’agente. Immaginiamo la quotidianità di un operatore: si muove in un panorama professionale dove i turni massacranti e disorganizzati privano del tempo necessario per un recupero autentico, sia fisico che mentale. A questo si unisce un sovraccarico burocratico che, sottraendo energie preziose al lavoro operativo, alimenta un profondo senso di frustrazione e insoddisfazione.
Il peso emotivo è poi costantemente aggravato dall’esposizione a situazioni traumatiche e dalla minaccia alla propria incolumità, che generano uno stato di allerta pressoché continuo. Questo carico, già di per sé considerevole, viene spesso moltiplicato da un ambiente di lavoro che può rivelarsi tossico, caratterizzato da dinamiche relazionali disfunzionali, episodi di mobbing o isolamento sociale che demoralizzano l’individuo e sgretolano lo spirito di squadra.
A completare un quadro già fragile contribuisce una cultura istituzionale che, spesso, non supporta adeguatamente la salute psicologica. Lo stigma legato alla richiesta di aiuto e la difficoltà a denunciare il proprio malessere creano un silenzio dannoso, lasciando che il confine tra vita privata e professionale – la già citata “sindrome da corridoio” – si dissolva completamente. In questo cortocircuito, le tensioni del servizio si riversano in famiglia senza filtri, e lo stress, non avendo più vie di fuga, cronicizza.
L’elemento che trasforma questa sofferenza latente in potenziale tragedia è, infine, l’accesso immediato alle armi da fuoco. Questa condizione operativa, peculiare della professione, rende le conseguenze di un malessere psicologico acuto estremamente più drammatiche e definitive. È l’interazione di tutti questi fattori a creare quel mix esplosivo di stress prolungato e non gestito che conduce al burnout.
L’isolamento dello sguardo altrui: il peso di non essere compresi
Ad aggravare ulteriormente questo quadro, si erge un muro di incomprensione spesso insormontabile. La figura dell’agente in divisa, percepita dall’opinione pubblica come un simbolo di autorità e invulnerabilità, nasconde in realtà una profonda solitudine. Questi operatori si trovano spesso a sopportare un carico emotivo che non possono – o non sanno – condividere. Il cittadino comune fatica a comprendere la specificità del loro stress; i familiari, pur amorevoli, possono non afferrare appieno le ombre che il servizio porta con sé dentro le mura domestiche; e, in alcuni casi, persino i superiori, imbrigliati in logiche puramente operative o di apparato, minimizzano o ignorano i segnali di malessere. Questa triplice incomprensione – pubblica, familiare e a volte istituzionale – genera un senso di isolamento profondo. La frustrazione di non sentirsi visti nella propria fatica e vulnerabilità diventa una lenta corrosione dello spirito, un veleno che alimenta il senso di inefficacia e spegne, giorno dopo giorno, la motivazione che aveva inizialmente spinto verso questa professione.
Conseguenze del burnout e dello stress: l’impatto a cascata
Partendo proprio da questo isolamento, gli effetti del burnout iniziano a manifestarsi in un progressivo e inesorabile deterioramento che colpisce la persona su tutti i fronti. Immaginiamo un agente, una volta appassionato e motivato, che inizia a mostrare i primi segni di esaurimento emotivo: non è più la semplice stanchezza di fine turno, ma un logorio profondo. A casa, non ha più la forza di giocare con i figli o di ascoltare il partner. Il sonno non ristoratore lo porta a essere irritabile e ipervigile anche in contesti sicuri, come se fosse ancora in servizio.
Sul lavoro, l’esaurimento emotivo apre la strada alla depersonalizzazione. L’agente, per proteggersi da un’ulteriore perdita di energie, sviluppa un cinismo difensivo e un distacco emotivo. Quel collega a cui un tempo dava una pacca sulla spalla diventa un “fastidio”; il cittadino che chiede aiuto non è più una persona in difficoltà, ma un “numero” o un “rompiscatole”. È un meccanismo di sopravvivenza disadattivo che, però, erode l’empatia, la compassione e lo spirito di squadra, fondamentali in questo lavoro.
La terza fase è il senso di inefficacia e ridotta realizzazione personale. L’operatore inizia a credere che il suo lavoro non serva a nulla, nonostante gli sforzi. “A che pro arresto uno spacciatore se domani ce ne sarà un altro?”, “Perché compilare questa pratica se tanto non cambierà mai nulla?”. Questa percezione di inefficacia si traduce in un calo oggettivo della performance: l’agente potrebbe mettere più tempo a redigere un verbale, commettere errori di distrazione durante un’ispezione o mostrare un pericoloso temporeggiamento negli interventi critici, mettendo a rischio sé stesso, i colleghi e la pubblica sicurezza.
Le ripercussioni sulla salute sono sia psicologiche che fisiche. Oltre all’ansia e alla depressione, lo stress cronico si somatizza. Possiamo vedere:
- disturbi gastrointestinali(gastriti, coliti) diventati la normalità;
- problemi cardiovascolari(ipertensione, palpitazioni);
- disfunzioni del sonno, dove l’insonnia si alterna a incubi ricorrenti con scene di servizio;
- un sistema immunitario indebolito, che rende l’agente più suscettibile a influenze e malanni.
Lo Stress Cronico come Soppressore Immunitario: il Meccanismo Biologico
Dal punto di vista fisiologico, lo stress cronico legato al lavoro agisce come un soppressore del sistema immunitario. In condizioni di stress acuto, l’organismo attiva una fisiologica risposta di “attacca o fuggi”, rilasciando ormoni come il cortisolo che, a piccole dosi, sono adattivi. Tuttavia, quando lo stress si protrae per settimane o mesi – diventando cronico – i livelli di cortisolo rimangono elevati, innescando un effetto soppressivo sulle difese immunitarie. Nel dettaglio, questa condizione porta a una riduzione della presenza e dell’efficacia dei linfociti T e B, cellule fondamentali per la risposta immunitaria specifica, e rallenta la produzione di citochine, le molecole che coordinano la comunicazione tra le cellule di difesa. Inoltre, lo stress cronico può alterare l’equilibrio del microbiota intestinale, che gioca un ruolo cruciale nel mantenimento di un sistema immunitario efficiente. Il risultato è una maggiore suscettibilità a infezioni ricorrenti, come raffreddori e influenze, un rallentamento dei processi di guarigione e l’instaurarsi di uno stato di infiammazione cronica di basso grado, un fattore di rischio per numerose patologie. In sintesi, il logorio psicologico da burnout non solo erode la salute mentale, ma compromette fisicamente la prima barriera di difesa dell’organismo.
Il deterioramento delle relazioni interpersonali diventa plateale. In caserma, l’agente tende a isolarsi durante le pause o a litigare per futili motivi. In famiglia, il coniuge si lamenta: “Non sei più quello di una volta“, “Sei sempre nervoso“. Gli amici di un tempo vengono gradualmente persi, perché “tanto non capiscono“.
L’effetto più tragico di questa spirale è l’aumento del rischio di comportamenti autolesivi, incluso il suicidio. Il pensiero “Sono un peso per tutti” o “L’unico modo per far finire questa sofferenza è…” può farsi strada in una mente esausta, resa ancor più vulnerabile dalla facile disponibilità del mezzo d’arma. L’allarmante aumento dei casi negli ultimi anni non è che l’ultimo, drammatico capitolo di una storia di sofferenza non ascoltata.
Anche un cambiamento forzato di mansioni, se gestito male, può essere l’ultimo colpo. Un agente operativo, costretto alla scrivania per un infortunio, può vivere questa condizione non come un riposo, ma come una morte professionale, un’umiliante dichiarazione di inutilità che acuisce il senso di fallimento.
Questi aspetti, concatenati tra loro, sottolineano l’assoluta necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di burnout. Non si tratta di “deboli che non reggono il mestiere“, ma di un logoramento professionale prevedibile e prevenibile, le cui conseguenze possono essere irreversibili per la salute degli operatori e per la sicurezza di tutti noi.
Strategia di prevenzione e intervento
È indispensabile un approccio multidimensionale per la prevenzione del burnout, che include:
- formazione emotiva già nelle fasi di addestramento per sviluppare competenze nella gestione dello stress;
- supporto psicologico diffuso e capillare con la normalizzazione del ruolo dello psicologo nelle forze di polizia;
- protocolli obbligatori di debriefing post-trauma e check-up psicologici periodiciper l’individuazione precoce dei segnali di disagio;
- miglioramenti organizzativicon revisione dei turni, riduzione della burocrazia e promozione di un equilibrio lavoro-vita;
- promozione di una cultura del benessereattraverso una leadership consapevole che riconosca e valorizzi la salute mentale come elemento centrale della professionalità.
Queste strategie, corroborate da evidenze scientifiche internazionali, devono essere adattate e implementate contestualmente in Italia per rispondere efficacemente alle esigenze specifiche degli operatori di polizia e ridurre l’allarmante fenomeno del burnout e dei suicidi.
Empowerment e Resilienza: Costruire Anticorpi Psichici
Accanto agli interventi strutturali, è fondamentale coltivare le risorse personali e di gruppo per trasformare la cultura del disagio in una cultura della resilienza. Se le strategie organizzative agiscono “dall’esterno”, l’empowerment e la resilienza sono gli “anticorpi psichici” che l’individuo e i gruppi di colleghi sviluppano per resistere allo stress cronico.
L’Empowerment in questo contesto non significa caricare l’agente di ulteriori responsabilità, ma restituirgli un senso di controllo e autoefficacia. Si concretizza attraverso:
- formazione avanzata sulle soft skill: insegnare tecniche avanzate di comunicazione non violenta, de-escalation e negoziazione per aumentare la percezione di padronanza nelle situazioni critiche;
- spazi di decisione condivisa: coinvolgere gli agenti nelle decisioni che influiscono sulla loro operatività quotidiana, per ridurre la frustrazione da imposizione dall’alto;
- peer education: creare figure di riferimento tra i colleghi, formate per riconoscere il disagio e offrire un primo, informale sostegno, normalizzando la condivisione delle difficoltà.
La resilienza è la capacità di “piegarsi senza spezzarsi”, ma per coglierne l’essenza più profonda possiamo ricorrere alla metafora dell’ostrica. Il trauma o lo stress cronico sono come un granello di sabbia che si insinua nell’esperienza professionale dell’agente, causando disagio. La resilienza, tuttavia, non consiste nel resistere passivamente o negare questo dolore, bensì nell’elaborarlo attivamente – un processo simile alla secrezione di madreperla. Attraverso un supporto psicologico adeguato, una formazione specifica e un ambiente di lavoro che non stigmatizza la fragilità, è possibile trasformare quel “granello” in una “perla”: un’empatia più matura, una competenza approfondita o una motivazione a diventare agenti di cambiamento positivo. La vera resilienza, quindi, non è solo sopravvivenza, ma rinascita e crescita attraverso le difficoltà.
Per sviluppare questa resilienza, è possibile allenare il proprio “muscolo psicologico” attraverso:
- training sulla consapevolezza (mindfulness): per riconoscere i primi segnali di stress nel corpo e nella mente, disinnescando il pilota automatico della reattività;
- psico-educazione allo stress: comprendere i meccanismi fisiologici dello stress (come quelli illustrati in questo articolo) riduce la paura e l’ansia ad esso associata, trasformandolo da un “mostro” incontrollabile a un processo fisiologico gestibile;
- potenziamento delle strategie di coping adattive:favorire la costruzione di una “cassetta degli attrezzi” personale che vada oltre l’evitamento, includendo tecniche di respirazione, gestione dei confini vita-lavoro e coltivazione di hobby rigenerativi.
L’obiettivo, in fondo, non è creare agenti invulnerabili, ma forgiare professionisti come perle: preziosi proprio per quelle stratificazioni nate da ferite trasformate in forza, dove la cicatrice non è un segno di rottura, ma il nucleo di un nuovo, più profondo splendore.
Investire su empowerment e resilienza non è un modo per scaricare sull’individuo le colpe di un’organizzazione disfunzionale. Al contrario, è il completamento necessario di un sistema di prevenzione integrato: un’organizzazione sana fornisce il terreno fertile, mentre individui resilienti e “autorizzati” sono i semi che in quel terreno possono non solo sopravvivere, ma rinascere, forti delle proprie cicatrici, come le perle lo sono della loro sabbia.
Conclusioni: dalla sabbia del dolore alle perle: la rinascita nelle divise
I dati allarmanti su burnout e suicidi non sono statistiche, ma il grido silenzioso di un sistema umano allo stremo. Abbiamo visto che questo male oscuro nasce da un mix di stress estremo e da una solitudine che isola gli agenti da tutti, persino da sé stessi.
Proteggere chi indossa la divisa significa abbattere questo muro di solitudine. È ora di sostituire lo stigma con l’ascolto e la diffidenza con una solidarietà concreta. La speranza è un’azione precisa: costruire una cultura della cura in cui chiedere aiuto sia visto come un atto di forza, l’unico modo per trasformare il trauma in resilienza, come un’ostrica trasforma un granello di sabbia in una perla.
Il nostro appello è un patto necessario. Solo un impegno congiunto di istituzioni, sindacati e psicologi, che ponga la persona al centro della divisa, potrà fermare questa emergenza. Guarire chi ci protegge non è un optional: è il fondamento di una società più sicura e davvero civile. Perché una società che sa curare i suoi protettori, sta proteggendo sé stessa.
NOTE BIBLIOGRAFICHE
-
- Carrer, F., & Garbarino, S. (2015). Lavorare in polizia: stress e burnout. FrancoAngeli.
- Figley, C. R. (1995). La fatica da compassione come disturbo da stress traumatico secondario: una panoramica. In C. R. Figley (a cura di), Fatica da compassione: affrontare il disturbo da stress traumatico secondario in coloro che curano i traumatizzati (pp. 1-20). Brunner/Mazel.
- Hickling, E. J., Reynolds, K., & Blakey, J. (2011). The psychological resilience of police officers in the United Kingdom.
- Istituto Superiore di Sanità (2022). Stress lavoro-correlato nelle forze dell’ordine: evidenze e misure di prevenzione. Roma: ISS.
- Lori, M. (2019). Lo stress del lavoro in Polizia e gli strumenti per affrontarlo. Formato Rivista, 2019-09.
- Meichenbaum, D. (2007). Stress inoculation training: A preventative and treatment approach. In P. Lehrer, R. Woolfolk, & W. Sime (Eds.), Principles and practice of stress management (pp. 497-518). Guilford Press.
- Ministero dell’Interno (2023). Relazione sul benessere psicologico e burnout nelle forze di polizia. Roma: Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
- Organizzazione Mondiale della Sanità (2023). Linee guida per la salute mentale negli ambienti lavorativi ad alto stress.
- Organizzazione Mondiale della Sanità (2023). Salute sul lavoro: prevenzione e gestione dello stress nelle professioni ad alto rischio. Ginevra: OMS Stampa.
- Palumbo, R., & Rossi, A. (2023). Supporto psicologico e prevenzione del burnout nelle forze dell’ordine italiane. Giornale Italiano di Psicologia, 50(2), 115-130.
- Pietrantoni, L., Prati, G., & Morelli, A. (2015). Stress e salute nelle forze dell’ordine. Laboratorio Polizia Democratica, 1, 1-20.
- Rischio stress: possibilità di valutazione con misure biologiche, Puntosicuro, 2018.
- Siulp Venezia (2019). Stress e burnout negli agenti di polizia: relazione definitiva. Venezia: SIULP.
- Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2018). Resilience: The Science of Mastering Life’s Greatest Challenges. Cambridge University Press.
- Stamm, B. H. (a cura di). (2010). Il manuale sintetico ProQOL (2a ed.). Pocatello, ID: ProQOL.org.
- Stress e Risposta Immunitaria, GAM Medical, 2024.
- Stress e sistema immunitario, Vitamin Center, 2025.
- Lo stress influisce sul sistema immunitario?, Auxologico, 2020.
- Lo stress indebolisce il sistema immunitario? Ecco cosa fare, Vivitapharma, 2025.
- Trevor, C., & Hart, P. M. (2022). Gestire lo stress lavorativo nelle forze dell’ordine: strategie basate sull’evidenza e ruoli di leadership. Pratica e ricerca della polizia, 23(5), 123-139.

ALTRI ARTICOLI DELLA STESSA AUTRICE
NON EROI, MA UMANI: IL DOLORE NASCOSTO DI CHI INDOSSA UNA DIVISA, UNA CORAZZA CHE UCCIDE
LA SINDROME DEL CORRIDOIO: QUANDO IL MURO TRA VITA E LAVORO CROLLA
LA FORME DELLA VIOLENZA SUL PARTNER E LA COLPEVOLIZZAZIONE DELLE VITTIME
ULTIMI ARTICOLI SULLO STRESS NELLE FORZE DI POLIZIA
UN ALTRO SUICIDIO TRA LE DIVISE, ADDIRITTURA UNA DONNA INCINTA DELLA POLIZIA LOCALE
LA DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE E MADRI NELLA POLIZIA LOCALE
APPLICARE IL COACHING STRATEGICO ALLA POLIZIA LOCALE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PREVENZIONE DEI SUICIDI NELLE FORZE DI POLIZIA
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
IMPORTANZA DELL’EDITING GRAFICO NELLE SCIENZE FORENSI
«IL 7 OTTOBRE DEL 2023 RIMANE E RIMARRÀ NELLE COSCIENZE COME UNA PAGINA TURPE DELLA STORIA»
ISLAMOFOBIA, ANTISEMITISMO E PREGIUDIZIO ANTICRISTIANO NEI MODELLI GENERATI DALL’IA
IL CLINICAL RESEARCH COORDINATOR (CRC): UNA FIGURA STRATEGICA PER LA CONDUZIONE DEGLI STUDI CLINICI
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0