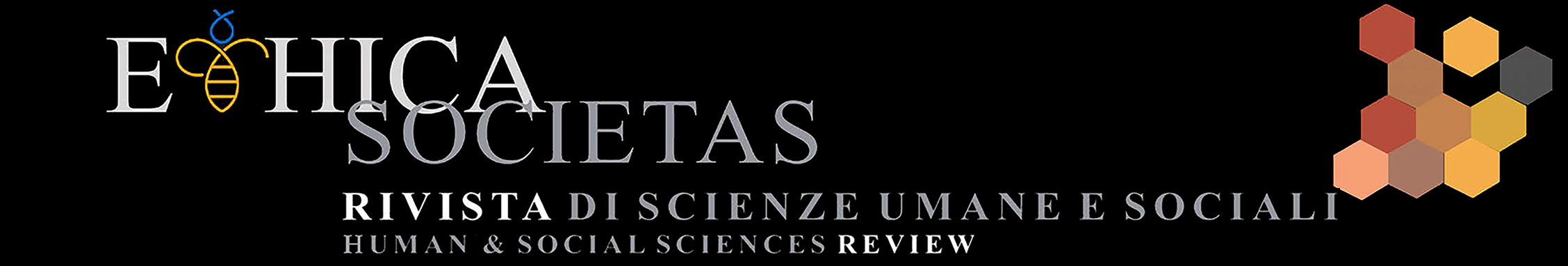Tra obblighi NATO, modernizzazione industriale e sostenibilità economica

Abstract: L’evoluzione della spesa militare italiana dal dopoguerra a oggi, in costane discesa dal 4,1% del PIL nel 1952 all’1,06% nel 2015, sale oggi esponenzialmente con il nuovo obiettivo fissato al 5% del PIL entro il 2035, deciso al vertice dell’Aia del 2025 imponendo all’Italia un forte incremento della spesa pubblica per adeguarsi agli standard dell’Alleanza. Nonostante le recenti dichiarazioni del ministro Crosetto sul raggiungimento del 2% entro il prossimo anno, restano dubbi sulla reale sostenibilità di un aumento che potrebbe portare la spesa annua oltre i 76 miliardi di euro, con pesanti implicazioni per i conti pubblici.
Keywords: #spesamilitare #NATO #difesa #PILItalia #bilancio2025 #politicaestera #verticeAia2025 #Crosetto #sicurezzaeuropea #pattodistabilità #investimentimilitari #strategia #economia #geopolitica #francescomancini #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #ethicasocietasupli
english version
LA SPESA MILITARE NELLA STORIA ITALIANA
Quando fu fondata la NATO, con il Trattato di Washington del 1949, l’Italia del dopoguerra spendeva in armi il 3,5% del PIL e la spesa salì per pochi anni sino al 1952, quando raggiunse il 4,1% del PIL, e da allora è scesa costantemente sino al minimo storico del 2015 quando ha raggiunto un valore di poco sopra l’1%. Nei successivi anni la spesa è aumentata ma ha superato di poco l’1,5% del PIL, tenendosi sempre al di sotto del 2% che è il vincolo di spesa per tutti i membri della NATO, come si può vedere nel grafico allegato [fonte dati Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del 26/06/2025].

A partire dagli anni ’60, la quota della spesa militare italiana sul PIL non ha più superato il 3%, proseguendo la tendenza al ribasso iniziata nei primi anni ’50. Tuttavia, fino al 1989 — anno della caduta del Muro di Berlino — il rapporto si è mantenuto stabilmente al di sopra del 2%, registrando solo lievi rialzi in alcuni anni isolati, come il 1966, il 1972 e il 1987.
Con l’inizio degli anni ’90, la contrazione è ripresa in modo costante, fino a toccare il minimo storico nel 2015, con una spesa pari all’1,06% del PIL. L’anno successivo al vertice NATO di Cardiff del 2014, in cui fu riaffermato con forza l’impegno degli Stati membri a destinare almeno il 2% del PIL alla difesa — impegno rafforzato dal contesto geopolitico dopo l’annessione della Crimea — la spesa italiana ha ripreso gradualmente a crescere.
Nel 2020 il rapporto ha raggiunto l’1,6%, non tanto per un aumento effettivo delle spese militari, quanto per la contrazione del PIL causata dalla pandemia di Covid-19. Nel 2024, la spesa militare italiana si è attestata intorno all’1,5% del PIL, corrispondente a una stima più precisa dell’1,46%.
LE NUOVE POLITICHE DI SPESA MILITARE EUROPEA E NATO
Il nuovo corso della politica estera del secondo mandato Trump, nell’ottica nazionalista del Movimento MAGA-Make America Great Again, ha portato a un forte disimpegno economico e militare degli USA nell’Europa, lasciando l’onere e soprattutto la spesa per la difesa ai paesi europei, vincolandoli nel contempo con la minaccia di ulteriori dazi ad acquistare armi americane, trasformando una voce di spesa in una entrata per gli Stati Uniti.
Al vertice tra i capi di Stato e i capi di governo dei trentadue Stati membri dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), dei loro Paesi partner e dell’Unione europea (UE), che si è svolto all’Aia, nei Paesi Bassi dal 24 al 25 giugno 2025, si è deciso un nuovo obiettivo di spesa per la difesa particolarmente ambizioso e costoso: entro il 2035 ognuno dei Paesi membri dovrà spendere il 5% del Pil, di cui almeno un 3,5% per “core military spending” e fino all’1,5% in “defence and security-related spending”.
Quindi il target di spesa militare NATO del 2%, che l’Italia non raggiungeva dal 1990, oggi si innalza a danno dei bilanci nazionali già oggetto di grandi tagli per rispettare il Patto di Stabilità sospeso solo durante il periodo della pandemia, per fronteggiare la minaccia Russa e compensare il taglio della spesa militare USA in Europa.
I NUOVI LIVELLI DI SPESA ITALIANI
Nel novembre scorso, durante un’audizione parlamentare, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva dichiarato che, grazie ai nuovi stanziamenti previsti nella legge di bilancio, la spesa per la difesa italiana sarebbe salita all’1,6% del PIL nel triennio 2025-2027.
Tuttavia, in un intervento più recente, lo stesso ministro ha fornito una stima diversa, presumibilmente in seguito a una riclassificazione di alcune voci di spesa militare secondo i criteri della NATO. Crosetto ha infatti affermato: «Abbiamo trasmesso oggi i nostri dati di bilancio alla NATO, certificando questo raggiungimento (del 2%, ndr). Sappiamo benissimo che le richieste che ci saranno al vertice di giugno rendono questo un punto di partenza.»
Resta tuttavia da verificare se la NATO accetterà tale riclassificazione, ovvero l’inclusione di alcune voci di spesa nel computo ufficiale delle risorse destinate alla difesa.
UNA DISTANZA STORICA DAI NUOVI OBIETTIVI
Negli ultimi settant’anni, il livello della spesa militare italiana si è mantenuto su valori significativamente inferiori agli standard fissati dalla NATO.
Mentre l’Italia ha oscillato attorno a una media dell’1,5% del PIL, il nuovo obiettivo del 3,5% rappresenta un incremento notevole, con conseguenze economiche e di bilancio rilevanti.
Tradotto in termini concreti, considerando il PIL del 2024, ciò equivarrebbe a passare da una spesa attuale di circa 32 miliardi di euro (secondo stime NATO), con un aumento di circa il 12% rispetto al 2024 e di oltre il 60% rispetto al 2016, a oltre 76 miliardi: un aumento di 44 miliardi, pari a circa il 57% della spesa pubblica per l’istruzione.
A questo importo andrebbero poi aggiunte le ulteriori risorse necessarie per raggiungere anche l’obiettivo dell’1,5% di spese “defence and security related”, che includono ambiti connessi ma non strettamente militari, ampliando così il fabbisogno complessivo.

ULTIMI 5 ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
«IL 7 OTTOBRE DEL 2023 RIMANE E RIMARRÀ NELLE COSCIENZE COME UNA PAGINA TURPE DELLA STORIA»
DRAGHI AL MEETING: L’EUROPA SMETTA DI RESTARE SPETTATRICE [CON VIDEO]
“UN CHIMICO”: LA SCIENZA E IL PREZZO DELLA NEUTRALITÀ EMOTIVA
PARTENOPE, NOI, LORO E GLI ALTRI
LE CONCLUSIONI DEL G7 SULLA PRIVACY [CON VIDEO INTEGRALE]
ULTIMI 5 ARTICOLI SUL TEMA DELLA GEOPOLITICA
QUANTO SONO IMPORTANTI PER TUTTI LE PROSSIME ELEZIONI NEL COMUNE DI NEW YORK CITY
IL VERTICE CHE NON CI SARÀ E IL DIRITTO CHE RIMANE IN BILICO
IRAN, TRA POTERE E PAURA: INTERVISTA A DAVOOD KARIMI
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA SUI REGOLAMENTI COMUNALI SUI RIFIUTI (Cass. civ. II sez. 25905/2024)
NON EROI, MA UMANI: IL DOLORE NASCOSTO DI CHI INDOSSA UNA DIVISA, UNA CORAZZA CHE UCCIDE
LA DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE E MADRI NELLA POLIZIA LOCALE
ISLAMOFOBIA, ANTISEMITISMO E PREGIUDIZIO ANTICRISTIANO NEI MODELLI GENERATI DALL’IA
IL CLINICAL RESEARCH COORDINATOR (CRC): UNA FIGURA STRATEGICA PER LA CONDUZIONE DEGLI STUDI CLINICI
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0