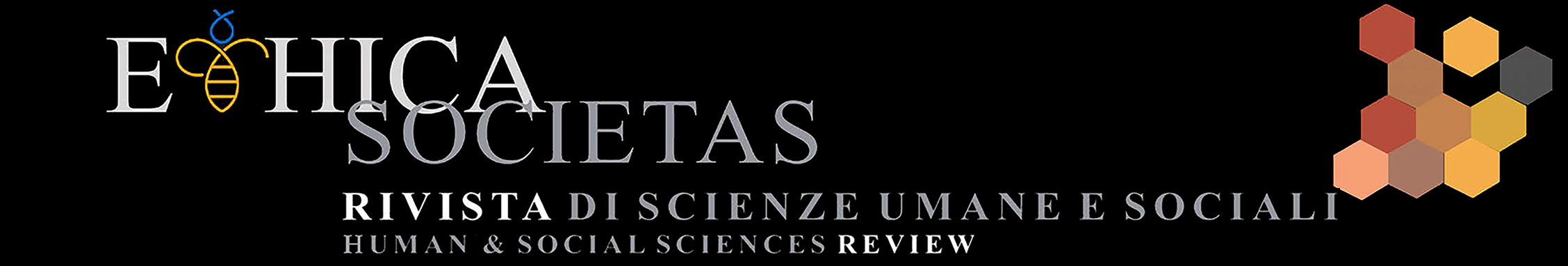Come l’algoritmo dei codici DRG ha trasformato la cura in valore misurabile, ridefinendo il rapporto tra medicina, efficienza e umanità negli ospedali moderni

Abstract: Il sistema dei DRG (Diagnosis Related Groups), introdotto per standardizzare i costi sanitari e rendere più efficiente la gestione ospedaliera. Nato negli Stati Uniti negli anni Settanta e adottato in Italia negli anni Novanta, il modello assegna a ogni ricovero una tariffa fissa in base alla diagnosi e alle procedure, separando la cura dai costi effettivi. Questo meccanismo ha portato maggiore trasparenza e controllo della spesa, ma anche rischi di rigidità e disumanizzazione della medicina. Oggi il sistema evolve verso modelli basati su qualità, performance e intelligenza artificiale, cercando un equilibrio tra sostenibilità economica e centralità del paziente.
Keywords: #Sanità #DRG #CostiSanitari #Ospedali #GestioneSanitaria #SanitàPubblica #Standardizzazione #EconomiaDellaSalute #RobertFetter #EfficienzaSanitaria #RiformaSanitaria #HealthcareManagement #PayForPerformance #IntelligenzaArtificiale #PoliticheSanitarie #EticaEDati #MedicinaEDiritto #MauroCofelice #EthicaSocietas #EthicaSocietasRivista #RivistaScientifica #ethicasocietasupli
I CODICI PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI
C’è un momento, in ogni ospedale, in cui la medicina incontra la contabilità. È un momento silenzioso, che avviene dopo che il paziente è stato dimesso, quando la sua storia clinica diventa una serie di numeri, lettere e codici. Quel fascio di dati si chiama DRG, acronimo di Diagnosis Related Groups, tradotto letteralmente “gruppi omogenei di diagnosi”. Dietro questo freddo acronimo c’è infatti uno dei meccanismi più importanti, e meno conosciuti, del funzionamento della sanita’ contemporanea: il modo in cui vengono pagati gli ospedali.
Immaginiamo un caso molto semplice: un paziente si presenta al pronto soccorso per una appendicite acuta. Viene operato, trascorre qualche giorno in reparto, poi viene dimesso. Per lui la storia è finita, ma per l’ospedale ne inizia un’altra, meno visibile ma altrettanto importante: tradurre quel percorso di cura in un codice DRG. È un po’ come se, finito un viaggio, qualcuno dovesse classificare il tragitto, il mezzo utilizzato, i chilometri percorsi e le spese affrontate. In ospedale questo avviene attraverso un sistema di codifica che analizza diagnosi, età, procedure, complicazioni e durata del ricovero, e così assegna al caso un gruppo di appartenenza. A ogni gruppo è associata una tariffa fissa: un’appendicite semplice costa una cifra, una appendicite complicata ne costa un’altra. Non importa quanto sia costato in realtà curare quel paziente, né quanti giorni sia rimasto in ospedale: la somma che verrà rimborsata sarà sempre quella relativa al suo gruppo di appartenenza.
COME IN UN RISTORANTE A MENÙ FISSO
È un meccanismo che, all’apparenza, può sembrare paradossale. Perché pagare la stessa cifra a chi ha speso meno o più? La risposta sta nel principio che anima i DRG: non pagare per quanto si spende, ma per ciò che si cura. Un ospedale efficiente, che riesce a curare bene i pazienti consumando meno risorse e tagliando i giorni di degenza inutili, viene premiato. Un ospedale che impiega più risorse di quelle necessarie non verrà pagato di più. È la logica del ristorante con menù a prezzo fisso: il piatto è quello, non importa se lo consumi in venti minuti o in un’ora. Negli anni Novanta questo sistema ha sostituito i vecchi rimborsi “per giornata di degenza”, che premiavano chi teneva i pazienti più a lungo, e ha rivoluzionato la cultura del management sanitario.
L’idea nasce negli Stati Uniti, negli anni Settanta, ed è soprattutto merito di un uomo poco noto al grande pubblico ma fondamentale nella storia della sanità: Robert Fetter, professore di management engineer a Yale. Il racconto che spiega la nascita dei DRG ha un sapore quasi da romanzo. Un giorno, il direttore di un ospedale del Connecticut chiese a Fetter: “Professor Fetter, quanto costa realmente curare un paziente qui dentro?”. Lui non seppe rispondere. A quei tempi nessuno lo sapeva con sicurezza: i costi erano sepolti in bilanci generici, senza alcuna relazione diretta con le cure. Fetter, incuriosito, iniziò a analizzare migliaia di cartelle cliniche, cercando schemi ricorrenti tra diagnosi, durata dei ricoveri e risorse consumate. Scoprì che, a parità di casi, gli ospedali spendevano cifre totalmente diverse. Da quella scoperta maturò un’idea semplice e geniale: se i pazienti possono essere raggruppati in classi clinicamente omogenee, allora anche i rimborsi possono essere calcolati in maniera standard.
Nel 1978 pubblicò, insieme al collega John Thompson, il primo studio sui Diagnosis Related Groups. Cinque anni dopo, nel 1983, il governo americano adottò ufficialmente il sistema per i rimborsi di Medicare, il programma sanitario federale. Per la prima volta nella storia, gli ospedali venivano pagati non per le giornate di degenza, ma per il tipo di cura erogata. Fetter spiegò il senso di questa rivoluzione con una frase rimasta celebre: “Non possiamo gestire ciò che non sappiamo misurare. E misurare, in sanità, non vuol dire ridurre l’umanità, ma darle un valore riconosciuto”. Era l’inizio di una nuova era: la medicina diventava anche una scienza dell’organizzazione.
LA STANDARDIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE IN ITALIA
L’Italia adottò il sistema DRG negli anni Novanta, adattandolo al proprio modello pubblico e regionale. Oggi ogni ricovero ospedaliero, sia in una struttura pubblica sia in una clinica privata accreditata, viene classificato con un codice DRG. Le Regioni stabiliscono le tariffe di rimborso, in base ai costi medi e ai tetti di spesa programmati. Così, un parto naturale, una protesi d’anca o una polmonite hanno ciascuno una cifra fissa, che varia da regione a regione ma risponde alla stessa logica di base. Gli ospedali privati accreditati vengono rimborsati con le stesse tariffe, in modo da garantire parità economica tra pubblico e convenzionato.
Il risultato è un sistema più trasparente e comparabile. Oggi i direttori sanitari possono sapere esattamente quanto “produce” ogni reparto, quali patologie sono più frequenti, dove si concentrano i costi e dove si annidano gli sprechi. Prima dei DRG, l’ospedale era una macchina opaca, in cui la spesa cresceva senza che nessuno potesse davvero collegarla alle attività svolte. Dopo i DRG, la gestione è diventata una questione di dati, di efficienza, di responsabilità.
I RISCHI DEL SISTEMA
Ma non tutto è semplice. Se il vantaggio dei DRG è la chiarezza economica, il rischio è la rigidità. Le tariffe si basano su medie, ma i pazienti non sono medie: ci sono persone fragili, con malattie multiple, che richiedono più tempo, più attenzione, più cure. Eppure, la cifra rimborsata resta la stessa. Un ricovero complesso può costare molto di più di quanto il DRG riconosca, e in questi casi gli ospedali pubblici, che non possono rifiutare nessuno, si trovano spesso in difficoltà. Non è raro che i medici ironizzino, dicendo: “Un tempo curavamo il paziente, ora anche il suo codice”. È una battuta amara ma precisa, che riassume la tensione continua tra efficienza e umanità.
Il sistema cerca di bilanciare questi aspetti attraverso controlli e correttivi. Le Regioni verificano la correttezza delle codifiche e possono sanzionare le strutture che dichiarano DRG inappropriati. Esistono professionisti specializzati, i coder, che hanno il compito di leggere le cartelle cliniche e tradurle nei codici esatti, una professione ibrida tra medicina e amministrazione. È un lavoro invisibile ma cruciale: da un codice errato può dipendere un rimborso sbagliato o un contenzioso.
L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA
Con il tempo, il modello DRG si è evoluto. Alcune regioni e molti Paesi hanno introdotto versioni più sofisticate, che tengono conto non solo della quantità ma anche della qualità delle cure. È la logica del pay for performance: non si paga solo per aver curato, ma per averlo fatto bene. Gli ospedali che dimostrano tassi di riammissione bassi, esiti migliori o maggiore soddisfazione dei pazienti possono ricevere incentivi aggiuntivi. In altri casi si sperimentano i pagamenti a pacchetto, che comprendono l’intero percorso di cura, per esempio dall’intervento chirurgico alla riabilitazione, in un’unica cifra. In questo modo le diverse unità operative sono spinte a collaborare, piuttosto che a frammentare i trattamenti.
L’intelligenza artificiale sta aggiungendo un nuovo livello di precisione. Oggi alcuni sistemi sono già in grado di verificare automaticamente la coerenza tra diagnosi e codici, individuando errori o incongruenze. In futuro, gli algoritmi potrebbero stimare in tempo reale la complessità clinica e il fabbisogno di risorse di ogni paziente, permettendo tariffe più flessibili e aderenti alla realtà. È una frontiera interessante, che riporta il sistema DRG al suo spirito originario: usare i numeri per capire, non per ridurre.
Per i cittadini tutto questo è invisibile, ma tocca da vicino la loro esperienza sanitaria. I DRG influenzano i tempi di ricovero, la disponibilità di posti letto, l’organizzazione dei reparti. Se negli ultimi decenni molte degenze si sono accorciate, se la riabilitazione è diventata più strutturata e se le cure ambulatoriali sono aumentate, lo si deve anche a questo sistema di finanziamento. I pazienti non vedono i codici, ma vivono gli effetti di un meccanismo che spinge gli ospedali a essere più rapidi, ordinati e responsabili.
LE CURE STANDARDIZZATE CHE NON TENGONO CONTO DEL BISOGNO
Eppure, dietro ogni codice, resta una storia. Un medico di lunga esperienza, raccontando di un paziente anziano che non voleva dimettere troppo presto, disse: “Il DRG era già maturato, ma lui no. Non sempre l’economia coincide con la medicina”. È in quella frase che si gioca il senso ultimo del sistema: il DRG non è la medicina, è solo il suo bilancio. Serve a rendere sostenibile ciò che, senza misura, rischierebbe di non esserlo più. Ma la misura, da sola, non basta.
Robert Fetter, il padre dei DRG, era consapevole di questo limite. Non smise mai di ricordare che i numeri non curano le persone, ma permettono ai sistemi di farlo meglio. Quando morì, nel 2019, un suo ex allievo disse che la sua vera eredità non era un algoritmo, ma un’idea di giustizia: che la salute non potesse dipendere dal caso, ma da regole trasparenti e uguali per tutti.
Oggi, ogni volta che un paziente viene ricoverato, dietro la sua cartella clinica c’è anche un codice, invisibile e impersonale. Ma è proprio grazie a quel codice che il suo letto, il suo medico e le sue cure esistono. La sanità, dopotutto, vive di questo equilibrio fragile tra numeri e persone, tra bilanci e speranze. È il compromesso inevitabile di ogni società che vuole curare tutti, non solo chi può permetterselo. E forse, se Fetter fosse ancora qui, direbbe che quel compromesso, imperfetto ma umano, è la forma più alta di misura che possiamo dare alla cura.

ALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE
ISLAMOFOBIA, ANTISEMITISMO E PREGIUDIZIO ANTICRISTIANO NEI MODELLI GENERATI DALL’IA
IL RISCHIO DI BIAS RELIGIOSO NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ALTRI ARTICOLI SULLA SANITÀ
IL CLINICAL RESEARCH COORDINATOR (CRC): UNA FIGURA STRATEGICA PER LA CONDUZIONE DEGLI STUDI CLINICI
LO STATO DELLA RICERCA SUI MENINGIOMI DI GRADO II E III
ULTIMI 5 ARTICOLI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA FINANZA AZIENDALE
L’ASCESA DEGLI AVATAR GENERATI TRAMITE INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ANALISI DI UN FENOMENO DIGITALE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BIAS: LIMITI E OPPORTUNITÀ
PAPA FRANCESCO SFERZA I GRANDI DELLA TERRA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE [CON VIDEO]
SUPERINTELLIGENZA: LA CORSA GEOPOLITICA E IL PARADOSSO NORMATIVO
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
L’EVOLUZIONE DELLA SPESA MILITARE IN ITALIA
LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA SUI REGOLAMENTI COMUNALI SUI RIFIUTI (Cass. civ. II sez. 25905/2024)
QUANTO SONO IMPORTANTI PER TUTTI LE PROSSIME ELEZIONI NEL COMUNE DI NEW YORK CITY
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0